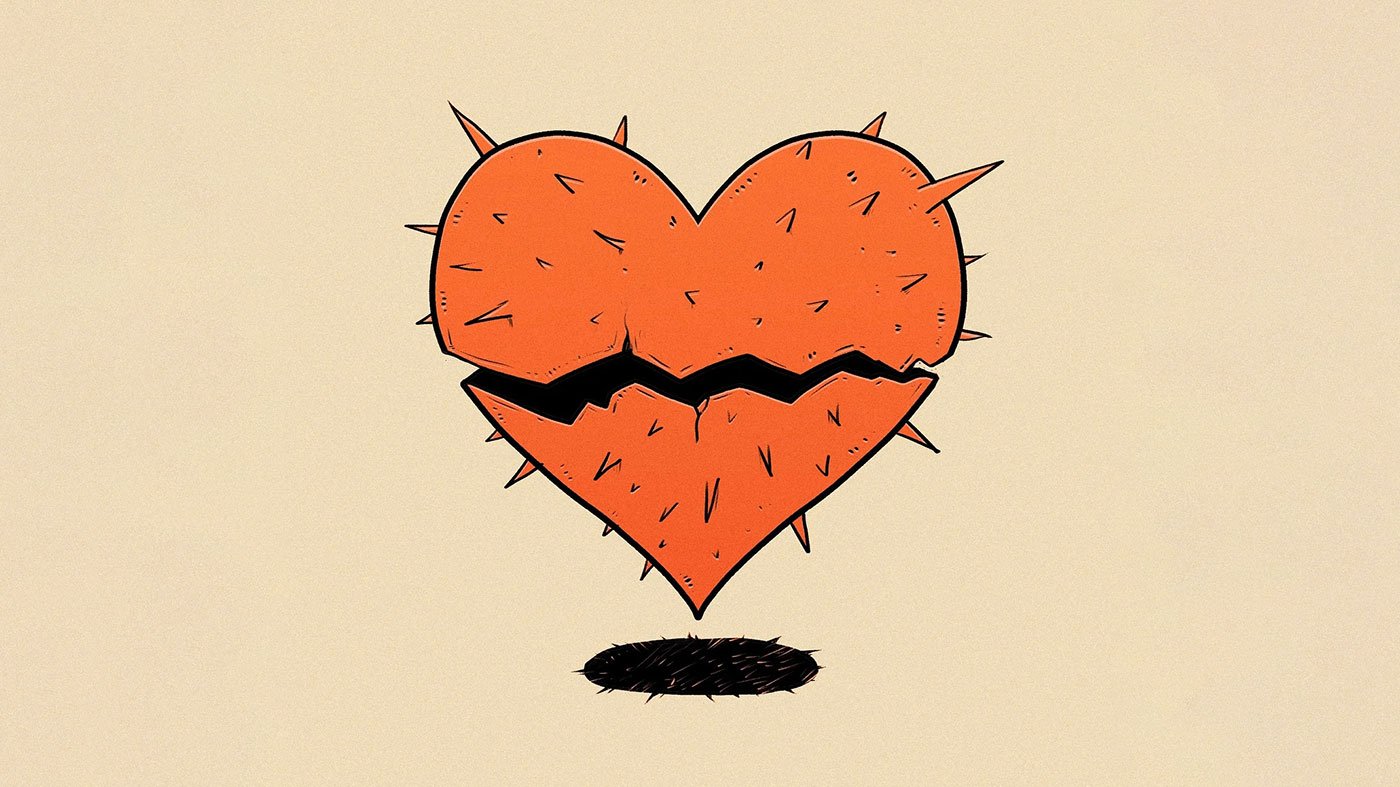Il Diritto Digitale: un ecosistema tutto da esplorare
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha catapultato in modo repentino in una dimensione “digitale” in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana.
In questa dimensione anche il diritto ha avuto una spinta in avanti nell'evoluzione del progresso di digitalizzazione: ci troviamo di fronte ad un vero e proprio ecosistema del Diritto Digitale tutto da esplorare nella terminologia e nei concetti nei quali ci imbattiamo quotidianamente.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza approntando una sorta di glossario.
Cosa intendiamo quando parliamo di diritto digitale, diritto dell’informatica, di diritto delle nuove tecnologie o diritto del web?
Quale è il ruolo del Giurista e come si pone in tutto ciò l’Avvocato 4.0?
Sommario
Il diritto dell'Informatica, il Diritto del web, il Diritto di Internet e della Rete
Il Diritto delle nuove Tecnologie (Law Tech): studio del progresso tecnologico
Conclusioni: l’ecosistema del Diritto Digitale
Il diritto dell’Informatica, il Diritto del web, il Diritto di Internet, il Diritto della Rete
Il nostro discorso non può non considerare in primis l’informatica giuridica, quale disciplina che studia i problemi giuridici connessi all'informatica ed alla telematica.
Il diritto dell’Informatica è volto prevalentemente allo studio delle vicende giuridiche nell'ambito del contesto telematico.
La telematica è un insieme di servizi informatici basati sul codice binario, offerti e fruiti, in tempo reale, attraverso una rete di telecomunicazione.
L'evoluzione e la diffusione delle tecnologie ha comportato un’autonomia formale e sostanziale del diritto dell'informatica che non è più una branca dell’informatica giuridica.
Perciò nell'ambito del diritto dell’informatica vengono ricompresi aspetti quali la libertà di comunicazione, la tutela dei dati personali, la rilevanza giuridica del documento informatico e delle firme elettroniche, la formazione e conclusione dei contratti del commercio elettronico, la proprietà intellettuale nel web, la responsabilità civile degli operatori in rete.
Appare chiaro quindi che nel diritto dell’informatica viene ricompreso anche il diritto del web o diritto di internet o diritto della rete, che spazia dalla tutela del copyright nella distribuzione elettronica, alla diffamazione online, al diritto all'oblio, al cyberbullismo e tutti quei fenomeni che rilevano sul web.
Il Diritto delle nuove Tecnologie (Law Tech): studio del progresso tecnologico
L’evoluzione tecnologica galoppante, Internet ed i nuovi strumenti di comunicazione stanno incidendo in modo sostanziale sull’evoluzione del diritto e soprattutto sulla tutela dei diritti stessi, sia come emersione di diritti nuovi, sia come contemperamento con i diritti tradizionali.
Il diritto delle nuove Tecnologie (Law Tech) è volto allo studio del progresso tecnologico dal punto di vista degli strumenti giuridici che regolano le nuove tecnologie.
E’ infatti indubbio che fenomeni quali: Blockchain, Smart Contracts, Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Thing (IoT), Machine Learning, stanno letteralmente esplodendo con applicazioni incisive nella nostra vita quotidiana e nel nostro ambito lavorativo.
L’Avvocato Digitale
Quale deve essere il ruolo del giurista e soprattutto dell’Avvocato nel contesto appena descritto?
Quali sono le sfide dell’Avvocato 4.0 quale professionista che deve reinventarsi di fronte ai nuovi scenari posti dalla tecnologia?
L’avvocato digitale si trova ad operare nel contesto del diritto come sopra delineato e deve trovare soluzioni giuridiche a problematiche sempre più collegate all'evoluzione delle tecnologie. Deve perciò rimodulare le proprie competenze professionali attraverso una formazione in cui c’è contaminazione tra il diritto e le nuove tecnologie.
In questo quadro operativo è tempo di andare di pari passo con l’innovazione, anzi di attuare l’innovazione e quindi di affrontare anche le sfide del mondo del Legal Tech e del Legal Design.
Il Legal Tech è la tecnologia applicata ai servizi legali, che consente di superare la modalità tradizionale dello studio legale, abbattendo i costi per i servizi legali che sono in qualche modo oggetto di standardizzazione (si pensi ad esempio al settore del recupero del credito, ma non solo).
Si tratta di un ambito ancora un po' ristretto, ma in fase di crescita positiva, come si evince chiaramente anche dall’evento annuale LegalTech Italia (alla terza edizione quella del 2019), quale momento di incontro delle start up legal tech italiane ed estere.
Il Legal Design è una disciplina multidisciplinare che trasforma in “visual” il contenuto di atti, documenti e procedure giuridiche, in modo da renderli più accessibili ed efficaci ai destinatari o utenti, ad esempio mediante delle infografiche o altre tecniche di grafica e comunicazione. In questo modo il mondo del diritto di apre ad una comunicazione più intellegibile ed efficace.
Conclusioni: l’ecosistema del Diritto Digitale
Abbiamo cercato di descrivere in pillole quello cha abbiamo definito ecosistema del Diritto Digitale inserito in un momento storico così particolare, unico oserei dire, in cui il digitale ha dimostrato di poter cambiare davvero il modo con cui le persone possono soddisfare i propri bisogni di vita e lavorativi,
Il digitale sta cambiando il modo con il quale ciascuno di noi cerca la soddisfazione di un proprio bisogno e lo fa sul web.
Ci siamo resi conto finalmente che “digitale” non significa disumanizzazione ed anche i servizi legali ed il mondo del diritto in generale possono trarre grandi vantaggi in termini di risposta veloce ed efficace: il cambiamento è ormai in atto e sarà certamente inarrestabile.
Come procurarsi la prova digitale del tradimento online
La Corte di Cassazione ha equiparato il rilievo del tradimento virtuale o digitale al tradimento fisico (Cass. Civ. I Sez., Ordinanza 16.04.2018, n. 9384): ciò significa che se il partner flirta online sui social network, tale comportamento può avere le stesse conseguenze di un tradimento fisico anche ai fini dell’addebito della separazione personale dei coniugi.
Appare però fondamentale poter fornire in giudizio la “prova” della relazione extraconiugale online.
Analizziamo i mezzi di raccolta delle prove e vediamo se sia sufficiente la semplice stampa dello screenshot del messaggio whatsapp o della pagina Facebook o se invece la raccolta della prova debba avvenire con l’ausilio della tecnologia.
Sommario
Lo screenshot è prova documentale in giudizio?
Come fornire la prova di una pagina web (per esempio Facebook)
Lo screenshot è prova documentale in giudizio?
La stampa dello screenshot del display di una chat di wathsapp o di una pagina facebook può essere depositata nell’ambito di un giudizio ai fini probatori.
Tuttavia occorre tenere presente che lo screenshot (ossia una sorta di foto istantanea dello schermo del dispositivo: smartphone, tablet, computer, ecc.) può essere facilmente alterata e modificata.
Di conseguenza lo screeshot fornisce in giudizio la prova del tradimento online soltanto se non è disconosciuto o contestato dalla controparte, come previsto dall’art. 2712 cod. civ.: la contestazione non può essere mai generica, ma deve essere sempre motivata in modo specifico e circostanziato.
È assai probabile che interverrà la contestazione della controparte, con la conseguenza che lo screenshot non potrà costituire una prova del tradimento. Tuttavia, anche in caso di contestazione, lo screenshot depositato potrà eventualmente rappresentare un indizio liberamente valutabile dal Giudice nell’ambito del giudizio in cui viene depositato.
Come procurarsi la prova dei messaggi contenuti nelle chat di messaggistica istantanea (whatsapp, telegram, messanger, sms, ecc)
La Giurisprudenza ha affrontato il tema dei mezzi di ricerca della prova informatica e della valenza probatoria dei messaggi contenuti nelle chat di messaggistica istantanea con soluzioni ancora non univoche.
Alcune sentenze hanno affermato che se il tradimento virtuale si è consumato in una chat di messaggistica istantanea (whatsapp, telegram, messanger, sms, ecc), una modalità che può essere utilizzata al fine di provare il tradimento online, e che può anche aggiungersi al deposito in giudizio della stampa dello screenshot, è quella di far testimoniare nel processo una persona che abbia letto direttamente il messaggio della chat e che sia disposta a testimoniare davanti al Giudice il contenuto visualizzato. E’ necessario che il testimone abbia letto direttamente il messaggio e che quindi non ne sia venuto a conoscenza per il tramite di altre persone.
Purtroppo questa modalità non garantisce il risultato di fornire la prova in modo certo, in quanto la prova per testimoni presenta sempre numerose incertezze conseguenti sia all’emotività del teste ascoltato dal Giudice, sia al controinterrogatorio che può fare l’avvocato di controparte con domande che potremmo definire a trabocchetto.
La Corte di Cassazione, V Sezione penale, nella Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 49016 ha chiarito, in merito alla trascrizione dei messaggi delle chat, che la conversazione tramite whatsapp ha valore probatorio a condizione che della registrazione – telematica o figurativa – sia acquisito anche il supporto (p.e. lo smartphone) della registrazione e non la sola trascrizione. Quest’ultima svolge una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Il supporto infatti consente di verificare l’affidabilità della prova mediante l’esame diretto del supporto medesimo al fine di verificare con certezza la paternità delle registrazioni e l’attendibilità di quanto da queste documentato.
Recentemente, il Tribunale di Reggio Calabria, richiamando il precedente della Cassazione appena riportato (Cass. n. 49016/2017), si è pronunciato con la sentenza n. 10 del 03.01.2019, precisando che, in quanto non è sempre possibile depositare il dispositivo originale, si può valutare il deposito della copia forense del dispositivo (p.e. lo smartphone) realizzata da un perito forense informatico, che redigerà una relazione tecnica forense descrittiva della metodologia e della strumentazione utilizzata per la copia forense medesima, che verrà depositata in giudizio. In definitiva è stato affermato che, sia nell’ipotesi che venga depositato il dispositivo originale, sia che venga depositato il suo equivalente tramite l’acquisizione forense certificata dal perito (copia forense), i dati possono essere utilizzati come prova nel giudizio.
Per creare una copia forense dei messaggi Wathsapp a uso legale (inclusi anche SMS, messaggi chat o gruppi Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messanger, Skype o qualunque sistema di Instant Messaging) è necessario che il perito si avvalga delle tecniche di acquisizione forense da cellulare, smartphone o tablet, basate sui principi di inalterabilità della prova e conformità con l’originale espressi dalla Legge n. 48/2008 e cioè le prove forensi debbono essere acquisite “adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”, “con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità”. Il tutto documentato nella relazione tecnica forense depositata in giudizio.
Acquisizione come prova di una pagina web (per esempio di una pagina Facebook o di altro Social)
Analizziamo quali possono essere gli ausili tecnologici da utilizzare per acquisire la prova del tradimento online rilevato su una pagina web, si pensi ad esempio ad una pagina o profilo Facebook, Twitter, Instagram o di altri social, purché si tratti di profili pubblici ai quali si può accedere liberamente.
Per fornire la prova forense di una pagina web è necessario rivolgersi ad un perito forense informatico che esegue la copia conforme della pagina web o copia forense, che viene realizzata utilizzando specifici software e seguendo determinate modalità che assicurino la conservazione dei dati e la immodificabilità (come già specificato). La copia forense potrà anche essere accompagnata dalla dichiarazione del Notaio circa l’autenticità e l’esistenza di quanto presente online su siti o profili social.
Infine sono disponibili sul web anche specifici Software che consentono in autonomia – senza l’intervento di un perito informatico - di creare la prova forense del fatto che determinati contenuti fossero disponibili online a una certa data e ora, garantendo anche la loro provenienza, la loro integrità ed inalterabilità a posteriori.
Conclusioni
Appare evidente che i Giudici stanno cercando in vari modi di allargare le maglie della producibilità in giudizio delle conversazioni tra privati e della dimensione dell’attività sul web. Si stanno orientando verso una visione “digitale” del diritto, dando rilievo, anche probatorio, alle situazioni online in quanto producono riflessi concreti nell’ambito della vita delle persone.
Per i magistrati, quindi, se vi è un interesse di causa e la corrispondenza è rilevante ai fini del giudizio, soprattutto nel diritto di famiglia, potrà essere utilizzata, anche solo come prova indiziaria, la conversazione senza invocare la privacy del diretto interessato, o potrà essere eseguita la “cristallizzazione” della prova della pagina web o della conversazione della chat di messaggistica istantanea, seppure, per ora, con le modalità ed i limiti che abbiamo visto.
Come si manifesta il Cyberbullismo: i rischi e le conseguenze
I ragazzi d’oggi vivono in una realtà sempre connessa. Interagiscono tra di loro tramite i profili social e comunicano tramite chat. Si trovano di fronte ogni giorno ad una realtà virtuale che spesso li conduce ad una dissociazione dalla realtà analogica.
Accade quindi che i giovani, anche minorenni, pongano in essere comportamenti e azioni illecite nascosti dietro la tastiera del computer o del telefono.
Dal mondo virtuale in cui l’azione è compiuta, passa ad incidere nel mondo della realtà, della vita “vera”, in cui la sofferenza legata all’umiliazione causata resta fissata, quasi cristallizzata ed impossibile da cancellare. Come si manifesta il cyberbullismo? Quali sono le conseguenze? Quali sono i tipi di cyberbullismo?
Sommario
Come si manifesta il Cyberbullismo?
Classificazioni delle azioni di Cyberbullismo
Come si manifesta il Cyberbullismo?
Internet annulla i limiti spazio-temporali dell’agire ed il cyberspazio si presta alla commissione di numerose fattispecie criminose, alcune tradizionali, altre del tutto nuove che spesso vanno oltre la molestia e sfociano in vere e proprie forme di violenza, che colpiscono la fragilità emotiva di altre giovani vittime.
Tali condotte restano impresse nella rete che “non dimentica” e che amplifica l’azione stessa in modo esponenziale ed aggressivo, causando alla vittima una sofferenza insopportabile che si trascina nel tempo, quasi come un marchio indelebile.
Dal mondo virtuale in cui l’azione è compiuta, passa ad incidere nel mondo della realtà, della vita “vera”, in cui la sofferenza legata all’umiliazione causata resta fissata, quasi cristallizzata ed impossibile da cancellare.
Tipi di Cyberbullismo
Cyberbullismo diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea, diretti esclusivamente alla vittima (es. sms, chiamate, e-mail, whatsapp), che producono un effetto immediato su di essa.
Cyberbullismo indiretto: il bullo utilizza aree pubbliche della rete (p.e. social network, blog, forum), all'interno delle quali anche altri utenti possono leggere i messaggi e/o vedere foto e video che il bullo pubblica e che molto spesso assumono un carattere di diffusione virale.
Esempi di Cyberbullismo
E’ possibile classificare i vari dei comportamenti che caratterizzano il fenomeno del cyberbullismo:
Flaming consiste in messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare vere e proprie battaglie verbali sui social network o nei forum.
Harassment (molestie), ossia l’invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico.
Denigration (denigrazione) e consiste nell’insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie.
Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d’identità), quando l’aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all’account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l’immagine e la reputazione della vittima.
Exclusion (esclusione) e consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l’obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione.
Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online), in questo caso si hanno minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica.
Outing (confessione pubblica di un fatto o un’esperienza personale) e trickering (Inganno), si tratta di comportamenti atti ad ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze.
Sexting: in questo caso si tratta di invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet.
Doxing: diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.
Conclusioni
Nel mondo virtuale, colui che agisce si sente forte della mancanza di limiti ed il filtro del mezzo tecnologico lo spinge spesso a compiere azioni molto più gravi, subdole e pericolose di quelle che lo stesso soggetto compirebbe nella vita reale. Risulta fondamentale un’educazione al digitale dei propri figli, valorizzando le opportunità della dimensione online, ma al contempo rendendoli sia consapevoli dei relativi rischi, sia della rilevanza di alcuni comportamenti come reati, con rilievi anche sul piano civilistico del risarcimento del danno.
Cyberbullismo: chi è responsabile e come denunciare
I giovani che mettono in pratica azioni di bullismo o cyberbullismo spesso commettono reati attuando comportamenti penalmente rilevanti, quali percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), molestie (art. 660 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), furto identità digitale (art. 640-ter c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Chi è secondo il nostro ordinamento il soggetto responsabile per l’azione compiuta dal soggetto minorenne?
Sommario
Se il soggetto minorenne ha compiuto 14 anni
Se il soggetto minorenne non ha compiuto 14 anni
Come denunciare in caso di cyberbullismo
Se il soggetto minorenne ha compiuto 14 anni
Per quanto concerne la responsabilità del soggetto, l’ordinamento italiano stabilisce che l’imputabilità penale (intesa quale responsabilità personale per i reati commessi) sussiste al momento del compimento del quattordicesimo anno di età.
Ciò significa che per poter avviare un procedimento penale, dinanzi al competente Tribunale di minorenni, nei confronti di un minore è necessario che lo stesso abbia compiuto almeno 14 anni e, comunque, anche se maggiore di 14 anni, è necessario che al momento del fatto fosse cosciente e volente, ossia in grado di “intendere e volere”.
D’altro canto, la responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dal soggetto minorenne può ricadere anche su altri soggetti, quali i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti e gli insegnanti e la scuola, in quanto nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica, il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa.
Se il soggetto minorenne non ancora compiuto 14 anni
Qualora, invece il minore non abbia compiuto i 14 anni, lo stesso non risponde penalmente per la condotta dannosa perpetrata, tuttavia, sussisterà dal punto di vista civilistico, la responsabilità dei genitori che saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Salvo che i genitori riescano fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, e poter essere esonerati dall’obbligo del risarcimento del danno causato dal figlio.
Si tratta nello specifico di una prova ardua in quanto è necessario poter dare evidenza certa:
- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato con attenzione e costanza sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Rileva che una condotta quale il cyberbullismo, che per sua definizione è reiterata, difficilmente sarebbe considerata quale fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.
Qualora il minore compia atti criminosi durante il periodo in cui è affidato alla scuola ed agli insegnanti (anche nel caso di scuola primaria), rilevano sia l’art. 2048 c.c., responsabilità dei precettori, sia l’art. 61 della L. 312/1980 n. 312, che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente.
In virtù delle citate normative infatti gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; mentre se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, ne risponderà la proprietà dell’istituto.
L’insegnante chiamato a rispondere deve dimostrare di aver adottato, per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.
Come denunciare in caso di cyberbullismo?
Nei casi più gravi, per attivare un procedimento penale è sufficiente la denuncia ad un organo di polizia postale o all’autorità giudiziaria (p.e. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, è necessaria la querela ossia la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato.